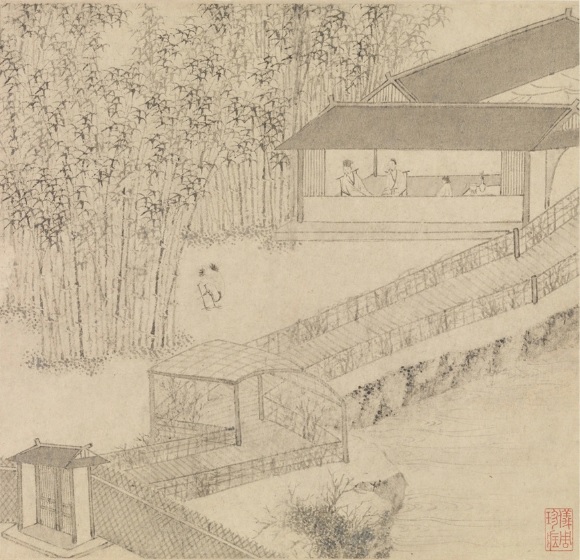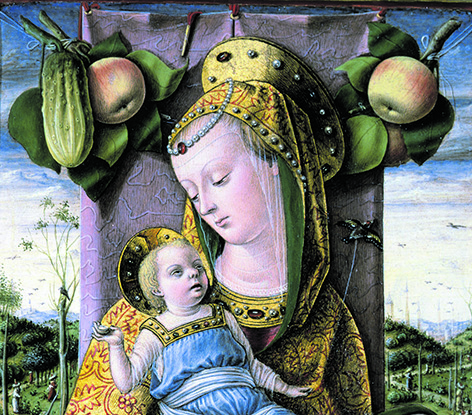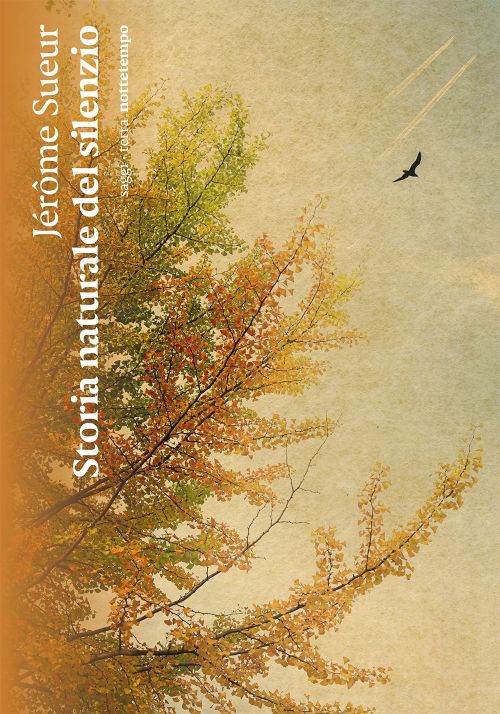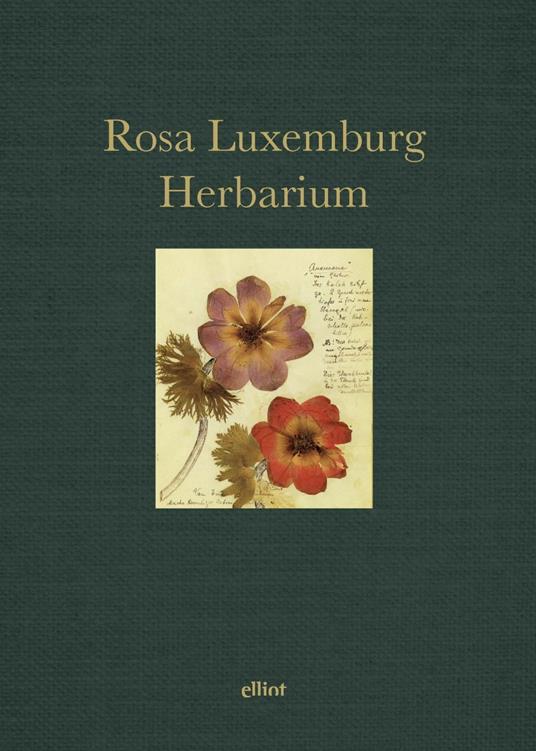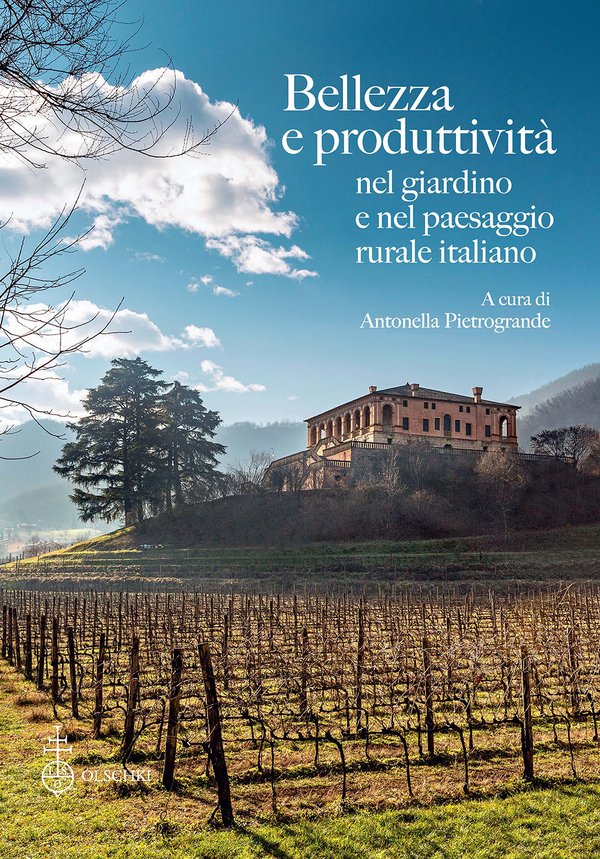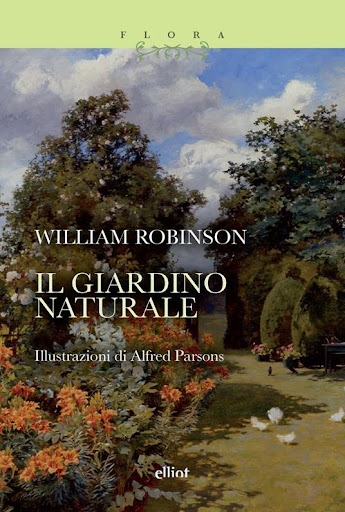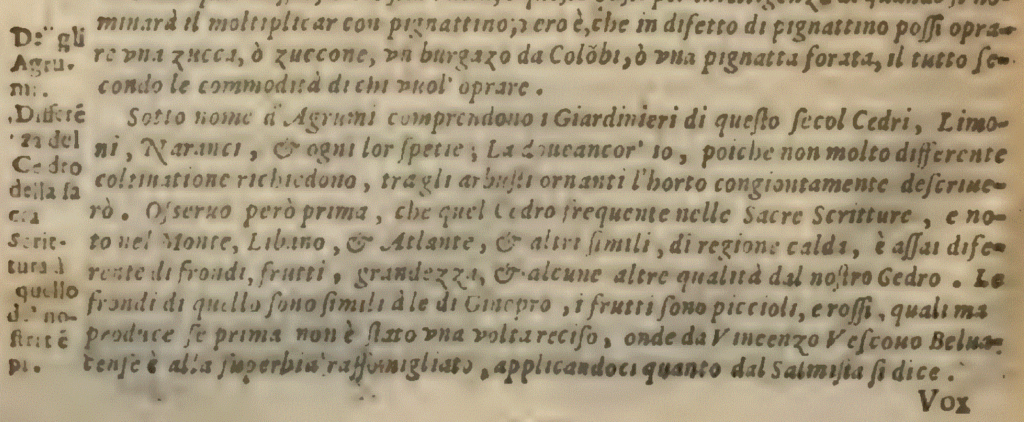Meglio che in qualsiasi altro ambito, fatta salva forse l’implicazione “atmosferica” che avvolgendoci ci nutre, la reciproca, inestricabile complementarietà dove acque e suoli, terre e mari si incrociano e interagiscono in dinamiche di vita porta a evidenza la dimensione che sempre più si va affermando come costitutiva di un paesaggio, come ormai si usa dire, senza bordi (Venturi Ferriolo). Una dimensione topologica, che rifugge separazione e misura, per la continuità, invece, dell’incessante concorrere trasformativo di dinamiche relazionali.

È quanto con anfibio procedere ci addita in vari modi dalle pagine del suo Mare paesaggio Daniela Colafranceschi (Libria, pp. 183, € 24,00). Ingegnandosi sui molteplici piani espressivi dell’analisi teorica e del progetto di paesaggio come forma di negoziazione (è pur sempre docente di tutto questo a Napoli) come pure su quello insolito dell’intellettuale memoir di epifanie e insight, dal Bosforo ad Algeri. E, specialmente, con le suggestioni evocate dalla serie dei suoi collage paesaggio. Un abecedario in dialogo di luci e ombre, pieni, vuoti, bianchi e neri distillati da fogli difettati di spessa carta realizzata a mano. Strumenti assieme di un operare progettando e per darsi conto di cardini e funzioni del pensiero di paesaggio. In un pervasivo, inesausto disegnare riflettendo, e viceversa, storie per temi. Una vasta e complessa geografia rifratta si compone così e ricombina per orizzonti ordinatori, spazi esistenziali, venti che improntano quel che attraversano, plurali singolarità delle genti, campi tramati da quelle esistenze, paesaggi urbani, rilievi e topografie dell’aderire e manipolare a un tempo. In questo caso poi, specialmente, si tratta dell’acqua nelle sue mille forme, di isole di arcipelaghi complici, rive come limiti e passaggi, stretti come dispositivi di rispecchiamenti, e assieme di fili, trame, scritture. Con l’idea di riconoscere alla relazione tra mare e terra uno statuto di paesaggio.
Così come la terra, anche il mare è un pieno. Di flussi, traiettorie, forme d’esistere, identità, modi di percepire ed esser percepiti, consuetudini, valori. Di cui aver cura nel governo e da intendere come grimaldello, bene comune
Di questo simultaneo appartenere, nei brevi, incisivi interventi del volume, si bordeggiano varie occorrenze. Dal progetto di un parco sullo Stretto di Messina che, proprio a partire dalla discontinuità immagina un’area metropolitana su sponde opposte, alla proposta di ripensare un’ampia area di risulta fattasi negletto margine costiero. Mentre dall’una all’altra costa la trama dei raccordi visivi s’intuisce laddove i resti dei forti umbertini costruiti con l’unità d’Italia secondo le traiettorie balistiche ancora si affrontano a presidiare nello stretto il territorio d’ingresso di quel braccio di mare.
Diversi i modi del mare di infrastrutturare il paesaggio.
Se quello della laguna veneziana dove i percorsi paralleli per calli e canali si incontrano soltanto al montare dell’acqua alta, è uno spazio ibrido di piazze liquide, con le scie sommerse di antichissimi letti dei fiumi che ancora disegnano sul fondo il tracciato delle vie d’acqua navigabili replicate in superficie dai pali delle briccole, il mare interno attribuito alle Canarie sul disegno che l’arcipelago tiene assieme in costellazione e si formalizza come “oceano territoriale”, mentre la geografia in ebollizione dei Campi Flegrei con annesso territorio sommerso del parco archeologico si misura con il vacillare finanche della linea di costa in una “ terraferma che ferma non è”, e il suolo liquido del mare abitato dei Paesi Bassi nel suo continuo sperimentare soluzioni negoziali si fa innesco e laboratorio per ripensare relazioni tra natura e città nel segno della centralità dello spazio pubblico.
Come un unico paesaggio, la continuità di mare e terra si disvela anche nel ripercorrere la storia delle curve di livello che siam soliti ricondurre all’indicazione della quota dei rilievi: mentre all’origine questa convenzione rilevava invece, sotto il livello del mare, il disegno delle possibili percorrenze per la navigazione in acque basse. Per innalzarsi solo poi, fuori dall’acqua, a imprimere con la cartografia militare un’unica condizione – mare o terra che sia – nel domino dei luoghi.

Stretti, golfi, arcipelaghi, porti, città, coste, territori intermedi al variar dell’orizzonte. In questo gioco di sguardi e rispecchiamenti in direzione da terra a mare, o al viceversa, o nell’attraverso da sponda a sponda, dove il limite è anche occasione di transito, scambio, ponte, margine di identità e appartenenza, strumento nel quotidiano o via di fuga, sempre prevale la logica del riconoscimento e il rilievo delle interrelazioni. Perfino in un Mediterraneo che tiene assieme geografie, genti e culture e che oggi troppo spesso si fa muro, fossa comune, spazio di separazioni e disuguaglianze “dove l’attraversamento determina un cambiamento di statuto giuridico da persone a emigranti”.
Daniela Colafranceschi, Mare paesaggio, Libria, pp. 183, € 24, recensito da Andrea Di Salvo su Alias della Domenica XIV, 6, Supplemento de Il Manifesto del 2 marzo 2025