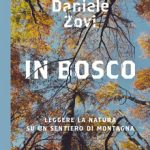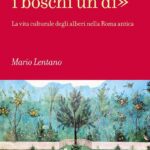Preso in prestito dal centauro Chirone nella pasoliniana Medea, il titolo del volumetto di Daniele Mongera, Niente di naturale, rinvia nella sua interezza a “non c’è niente di naturale nella natura”, a significare qui l’irriducibile, inestricabile tensione di afflati, del giardiniere, a cui con la natura spetterebbe tenere il filo del dialogo, come del paesaggista, che, nell’artificio, creativamente resta a distanza, votato alla meraviglia dell’inutile (Officina Naturalis Editore, pp. 124, € 12,00).
Animatore d’imprese come Maestri di giardino, dove trasferire in scrittura sensibilità, saperi e saper fare, nonché ora di questa Officina Naturalis con già diversi titoli all’attivo, Mongera inanella una serie di testi che, con un’attenzione al guscio etimologico delle questioni capace assieme di plastiche, immaginifiche invenzioni, illuminano snodi, episodi, personalità della recente storia del giardino con la competenza dotta delle vicende che pochi compartecipi possiedono.
Che sia la rivoluzione culturale e linguistica avviata a metà anni settanta dalla penna con vocazione pedagogica di Ippolito Pizzetti (e dalle sue imprese editoriali) che, ben oltre i temi consueti della tradizionale storia del giardino, introduce il suo pubblico – quasi creandolo – a riconoscere caratteri delle piante e fisionomie del paesaggio con la coscienza critica di un modo nuovo di far giardino calato nell’attualità del sociale.
O la vicenda del rinascimento e declino del giardino italiano illustrata in un’essenziale Fenomenologia delle mostre mercato. Dall’esordio delle esposizioni di piante rare e insolite per un ristretto pubblico di appassionati che con i primi anni novanta e l’introduzione accurata di erbacee perenni e piccoli arbusti disseminano lavoro e stile, spesso eclettico, di un certo vivaismo di ricerca, specializzato in raccolte e collezioni botaniche, svecchiando il vocabolario dei nostri giardini, fino al successo di un fenomeno che con il nuovo millennio invade piazze, cinte murarie e parchi pubblici. Per finire però, sempre più condizionato dal mercato, per adagiarsi, spersonalizzandosi, su registri nazionalpopolari.
Salvo ancora, pur tra mille diffidenze, testimoniare dell’affermarsi di quell’altro grande capitolo dello stile che si lega ai temi della biodiversità, della bassa manutenzione, della scarsità, del secco, con un’attenzione nuova verso il naturale che, superato l’imbarazzo per la somiglianza con erbacce, si traduce nell’affacciarsi “ecologico” sulla scena del giardino della grande famiglia delle graminacee.
Daniele Mongera, Niente di naturale, Officina Naturalis Editore, pp. 124, € 12,00, recensito da Andrea Di Salvo su Alias della Domenica X, 6, Supplemento de Il Manifesto del 9 febbraio 2020