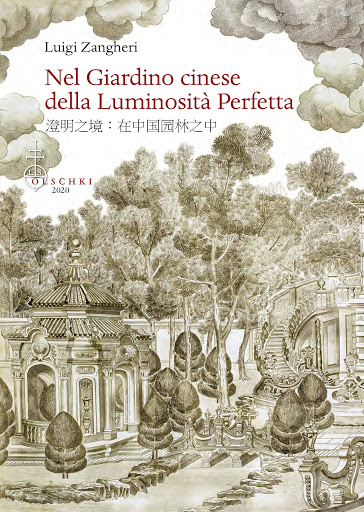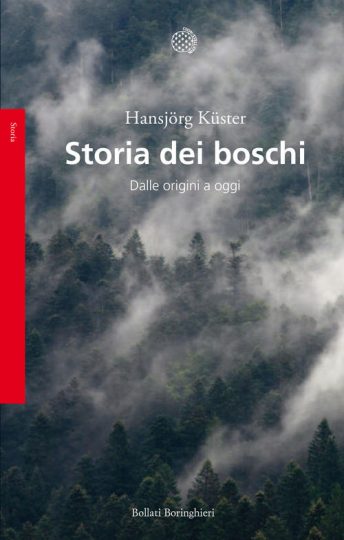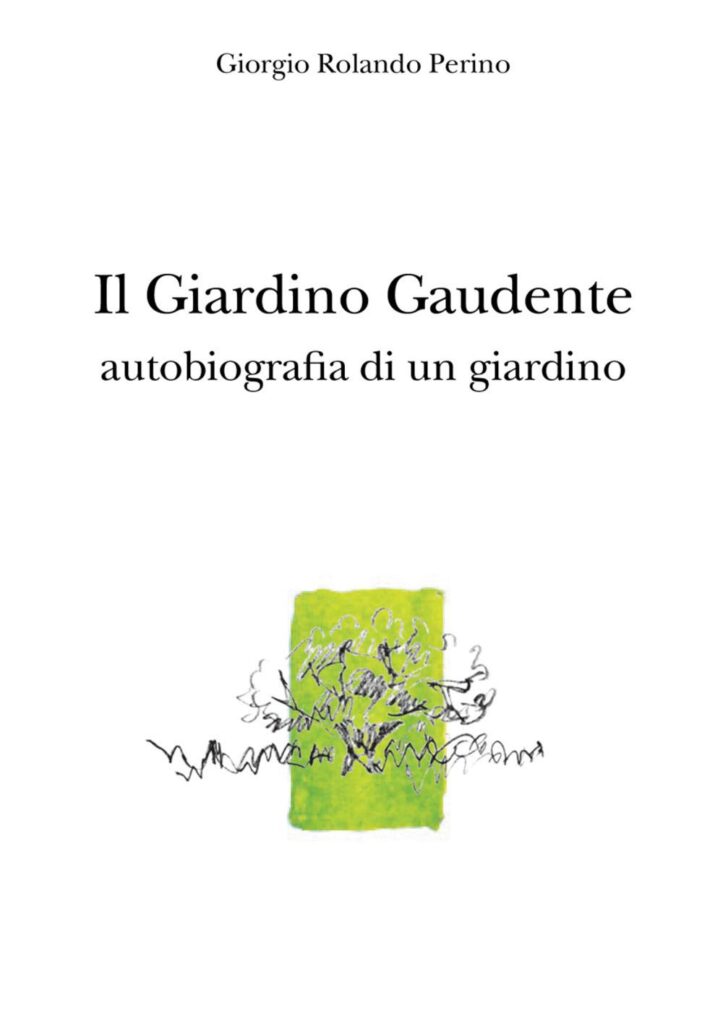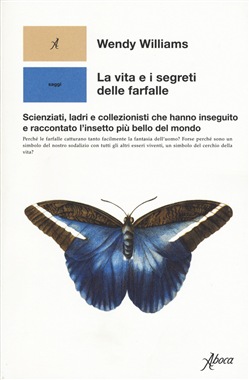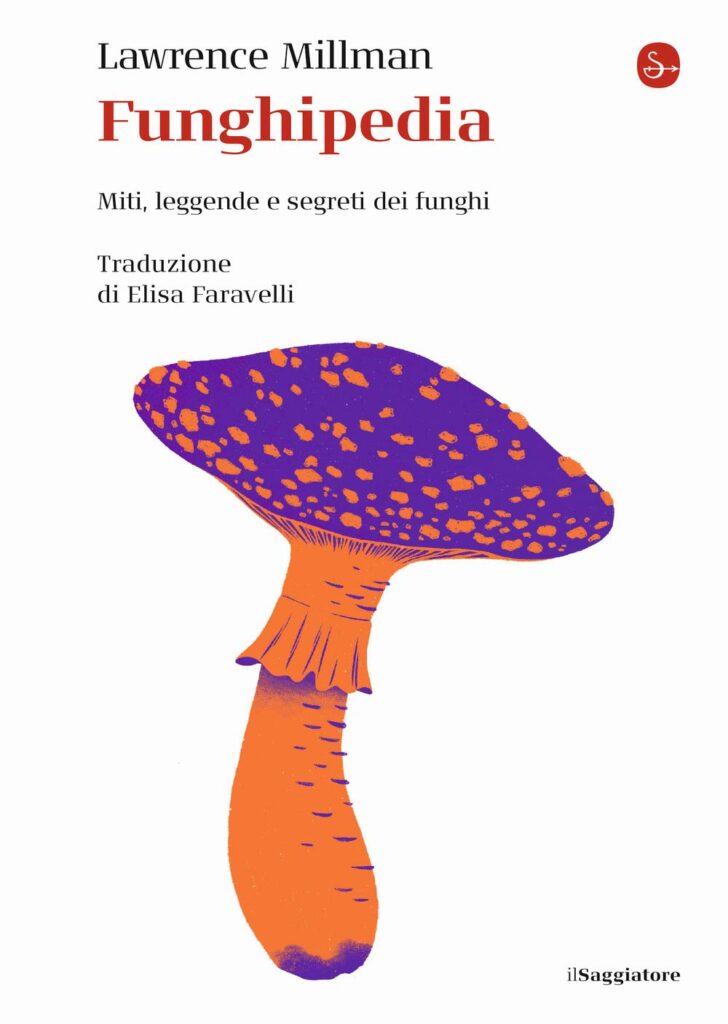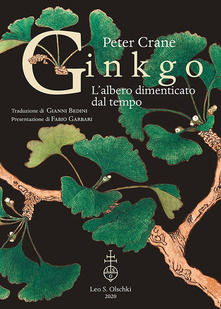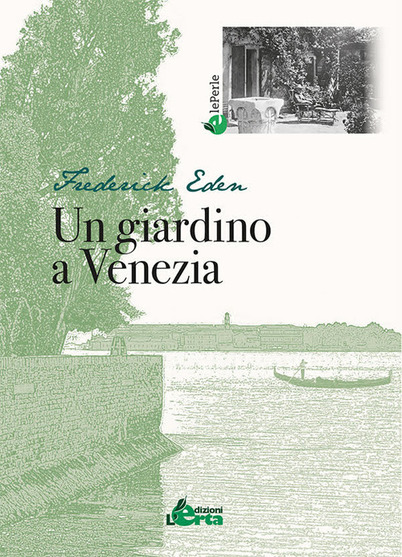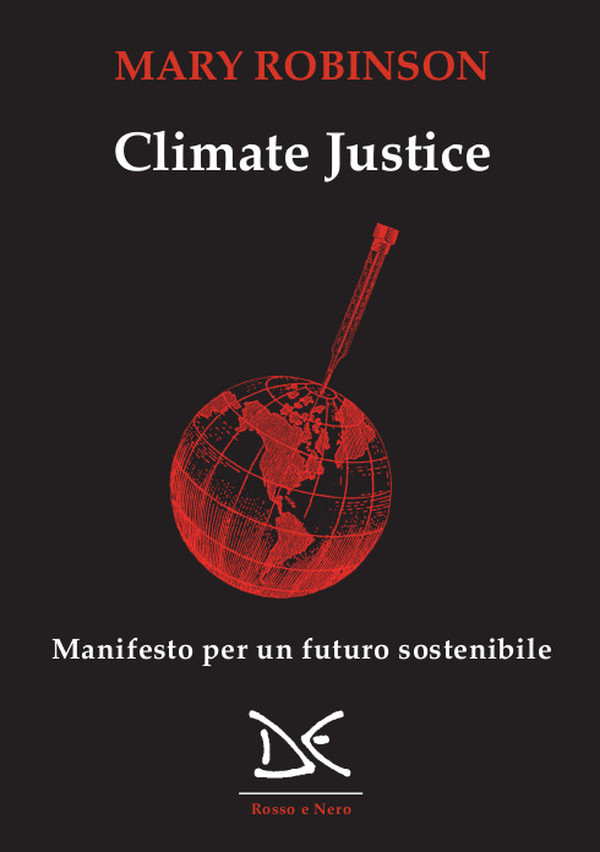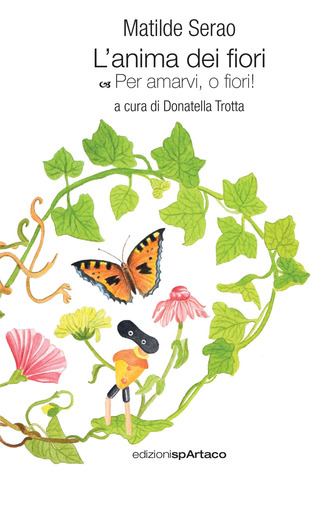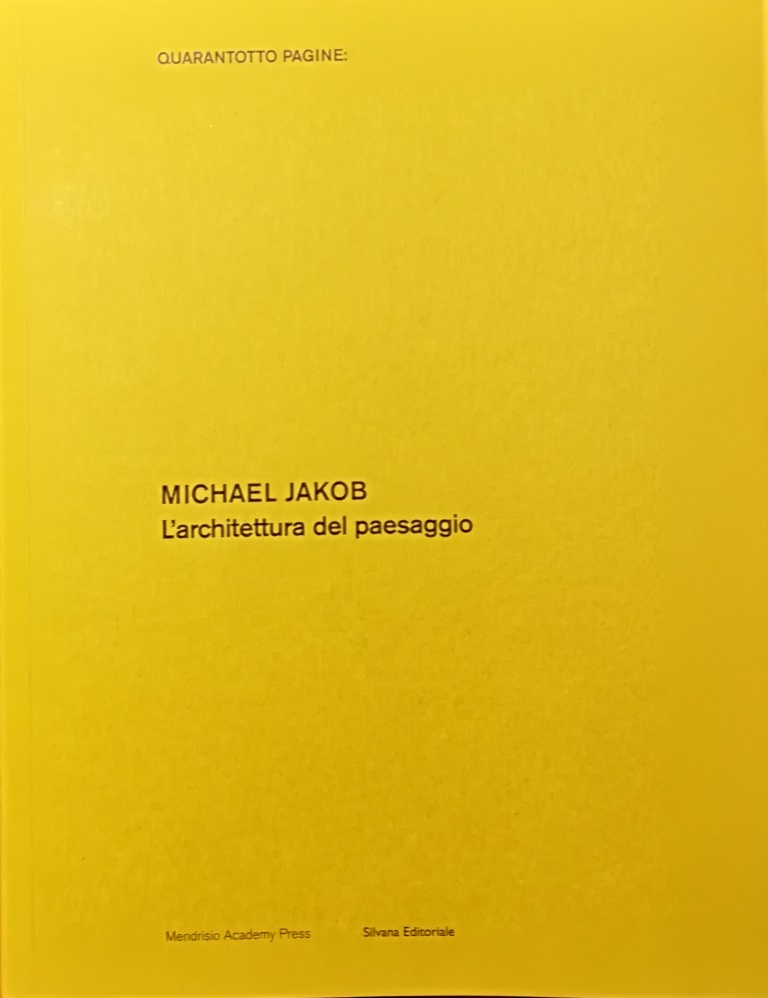
Facendo perno sul concetto chiave di paesaggio, irriducibile e polisemica definizione di campo che sotto il segno della dimensione estetica si costituisce attraverso il nostro lo sguardo (corporeo) come ritaglio di natura, e che assieme opera però praticamente a cavallo di ambiti e scale di intervento e all’intersezione di saperi, Michael Jakob, docente, saggista, curatore di mostre, torna a distillare le sue riflessioni su L’architettura del paesaggio (Silvana editoriale, Mendrisio Academy Press, pp. 48, € 10.00).
Procedendo a evidenziar paradossi su come il paesaggio s’imponga come esperienza per la sua qualità folgorante, tanto quanto incondivisibile (l’incomunicabilità evocata dalle figure di spalle delle tele di Caspar David Friedrich), su come il paesaggio sussuma a un tempo eventi mentali ed artefatti, sia reazione radicalmente individuale eppure quanto collettiva nei modelli culturali che la originano, Jakob introduce qui la proposta di un Atlante critico che descriva e interpreti le opere realizzate durante la, tutto sommato, breve vita della disciplina (almeno a farla partire dal paesaggista moderno Frederick Law Olmsted con il suo fondativo Central Park).
Per tappe infinite di riformulazioni e ritocchi, in un crescendo che – come il progetto (che pensa l’insieme in termini processuali) e l’insegnamento teorico – non arriva mai, la forma Atlante, proprio nella sua incompiutezza strutturale, consente di avanzare elaborando conoscenze per via di composizione critica di oggetti. In un corpus che, all’insegna della differenza piuttosto che non dell’identità, possa ibridare il modello produttivistico dell’architettura e le logiche ricettive di una trasversale prospettiva paesaggistica. Nella misura breve delle Quarantotto pagine che intitolano la collana, un catalogo ragionato necessario per dar conto di una storia non ancora scritta, di cui si lascia intravedere l’andamento nella ventina di progetti inanellati nelle immagini delle tavole a corredo.
Michael Jakob, L’architettura del paesaggio, Silvana editoriale, Mendrisio Academy Press, pp. 48, € 10.00, recensito da Andrea Di Salvo su Alias della Domenica X, 44, Supplemento de Il Manifesto dell’8 novembre 2020