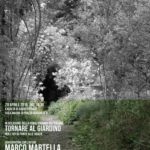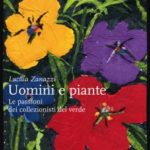Stenta ancora ad affermarsi nel senso comune l’evidenza che quella complessa molteplicità di relazioni che chiamiamo paesaggio (variabili naturali, culture materiali, proiezioni mentali) non sia soltanto un lascito del lavoro e della sapienza delle generazioni precedenti, quanto piuttosto l’esito in divenire della nostra capacità di reinterpretarlo creativamente. Aggiungendovi ogni giorno il protagonismo contraddittorio delle nostre tante attualità. Eppure, questa consapevolezza comincia talvolta a farsi condivisa, fino alla presa di parola e di responsabilità da parte delle comunità dei luoghi. E ciò va insieme al progressivo diffondersi di una cultura del “paesaggio vissuto” fatta di educazione continua dello sguardo e dei sensi, delle emozioni e dei saperi, ma anche di formazione e divulgazione, del convergere di conoscenze ultradisciplinari, imperniate su una visione strategica e un’articolata metodologia progettuale.
La figura connettiva dell’architetto del paesaggio gioca da tempo un rilevante ruolo specifico nel costruire e promuovere questa cultura. Prospettando anche in Italia, seppure con un certo ritardo, l’importanza di competenze che, nel quadro di un approccio interdisciplinare, intervengano nell’ideazione e nella progettazione di quelle che vengono oramai definite “infrastrutture verdi”: a dar conto della valenza di sistema che tale coordinata molteplicità di interventi assume innervando alla più diversa scala l’intelaiatura sociale, abitativa, produttiva, conformandone aspirazioni e immaginario.
Organizzato dai paesaggisti dell’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, si terrà quest’anno in Italia, dal 20 al 22 aprile al Lingotto di Torino, il 53° Congresso mondiale dell’International Federation of Landscape Architects, l’organismo che coordina le 74 associazioni nazionali di architettura del paesaggio strutturate nel mondo in 4 macro regioni.
Il confronto sul tema che intitola la tre giorni, Tasting the Landscape, è un invito accorato a considerare anche la componente emozionale e percettiva dei paesaggi, qui opportunamente privilegiati nella dilagante dimensione liminare costituita dai paesaggi peri-urbani, tra città e campagna. Una serie di realizzazioni dai più diversi contesti verranno proposte con la possibilità di valere come buone pratiche. Un documento conclusivo di sintesi e indirizzo verrà condiviso e portato all’attenzione di cittadini e politici, richiamandoci alla responsabilità comune che ci vede tutti comunque operare sul paesaggio, magari in negativo, astenendoci e pagando così i costi del “non fare”, oppure procedendo ex post, per emergenze. O invece assaporando il gusto di un paesaggio consapevolmente ipotizzato, sbilanciandosi nel segno della sperimentazione, enunciando indicazioni a procedere in dialettica serrata con altri pareri, idee, processi partecipativi. Nella convinzione che una rinnovata consapevolezza del valore del paesaggio sia premessa di una condivisa, civile assunzione di responsabilità.
Intervista con Anna Letizia Monti, presidente della Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio in occasione del 53° Congresso mondiale dell’International Federation of Landscape Architects che si terrà quest’anno a Torino, al Lingotto, dal 20 al 22 aprile

The Peace Monument, or: God with us, sketch per il disegno realizzato poi attraverso il taglio dell’erba al Monument of the Battle of the Nations a Lipsia 2013. Un approccio minimale e dirompente per percepire con occhi nuovi paesaggi consueti nell’intervento di un paesaggista e di un artista, Torsten Wilke e Ralf Witthaus
Nella dichiarazione programmatica del 53° Congresso mondiale dell’International Federation of Landscape Architects che si terrà quest’anno a Torino, al Lingotto, dal 20 al 22 aprile organizzato dall’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, la presidente, Anna Letizia Monti, si dice certa che “anche a livello nazionale i politici, gli amministratori, l’opinione pubblica stiano finalmente riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante per la qualità della vita delle popolazioni”. Le chiediamo se il grande sforzo organizzativo che porterà a Torino oltre 1000 specialisti del paesaggio non deve scontare, specialmente in Italia, la convinzione difensiva, che pure non manca di buone ragioni, che vede il paesaggio ancora troppo spesso considerato soltanto come qualcosa da ammirare e tutelare, conservandolo eguale a sé stesso. Mentre il messaggio del vostro incontro pone l’accento su un progetto di paesaggio che si collochi operativamente al centro delle attività di crescita e sviluppo del Paese. Come si conciliano questi punti di vista?
R Non è più il tempo di pensare al paesaggio come elemento iconico e celebrativo. Il paesaggio è una realtà dinamica, che si evolve, muta e si trasforma. È parte integrante della vita quotidiana dei Paesi e delle popolazioni e partecipa con essi al mutare delle necessità, ai nuovi usi.
Il paesaggio si fruisce in molteplici modi e funzioni e si può declinare come spazi urbani e periurbani per favorire rapporti e relazioni; come aree cittadine e rurali con impianti arborei finalizzati alle attività ricreative e al miglioramento della qualità dell’aria; come siti densi di stratificazioni e destinazioni passate che si rinnovano per produzioni alimentari di contiguità o per poetiche partecipative.
Il nostro Paese è in ritardo su molti di questi temi, ma è giunto il tempo di (re)agire.
Il Congresso ha anche questo obiettivo: evidenziare le necessità, risvegliare gli animi, suggerire soluzioni per poter avviare coscientemente e sistematicamente progetti e realizzazioni paesaggistiche che siano parte integrante delle politiche di questo Paese che – purtroppo – è in ritardo di decenni sulla realizzazione di normali progetti di paesaggio, reali e possibili.
D In questo tipo di consessi c’è spesso il rischio di parlare a se stessi invece di assumersi il rischio di dettare, quasi imporre al dibattito alcuni temi forti. Potrebbe introdurci alle ragioni della scelta di un titolo come Tasting the Landscape e della sua articolazione nei 4 filoni di approfondimento?
R Si è scelto di indagare gli ambiti del progetto di paesaggio a tutto tondo: la risignificazione sensibile dei luoghi, le criticità delle aree marginali, le coltivazioni di prossimità, i paesaggi stratificati, le poetiche del vivere quotidiano.
A Torino si indaga sui paesaggi condivisi: le aree fra città e campagna, residenza e coltivazione agricola, produzione industriale e abbandono. Sono paesaggi che possono e devono creare legami, condivisioni e dare valore a luoghi, persone, idee e produzioni; sono le aree per l’agricoltura urbana, sono i periurbani non più in attesa di essere urbanizzati ma che risorgono a vita nuova.
Ci confrontiamo sui paesaggi connessi: quelle infrastrutture verdi e blu, che servono per creare connessioni, unioni, continuità fra territori e persone contigue. Luoghi in cui coesistono produzioni e attività sportive, resilienza e turismi.
Si affronta poi il tema dei paesaggi stratificati, in cui coesistono e dialogano le storie e le mutazioni dei luoghi. Siti in cui passato e presente hanno codici di relazione precari e per i quali il paesaggista deve individuare semantiche per la complementarietà e la coesione.
Si studiano infine i paesaggi d’ispirazione: luoghi in cui si concretizza una risignificazione dell’esistente o si declinano nuove poetiche per il vivere.

Intervento di Gianluca D’Incà Levis nell’ambito del progetto Dolomiti Contemporanee per la riappropriazione di spazi e il riuso di edifici che rendono vivi e attivi paesaggi e popolazioni.
D Vista la pluralità degli interventi e dei progetti che verranno presentati potrebbe anticiparci alcuni casi concreti dai quali vi attendete suggestioni e soluzioni che, seppur legate ai diversi contesti d’origine, potrebbero assumere un valore esemplare e lasciar intravedere tendenze e sviluppi futuri?
R I lavori vedranno l’intervento di figure di primo piano del dibattito internazionale come Raffaele Milani, docente di estetica e filosofia del paesaggio; Henri Bava, paesaggista francese che ha all’attivo numerosi progetti di riqualificazione di paesaggi degradati; Saskia Sassen sociologa ed economista statunitense che indaga da anni il tema della città globale.
La novità, se tale la vogliamo considerare, è che non sono ormai soltanto i Paesi Europei e gli Stati Uniti ad avere politiche e consuetudini attuative per il progetto di paesaggio, ma anche la maggior parte degli altri Paesi. A Torino verranno presentati un progetto di 1.000 ettari di agricoltura urbana a Pechino, contributi dell’Università di Teheran, progetti di valorizzazione dei paesaggi turchi nell’entroterra di Mersin, piuttosto che del sud ovest della Nigeria: è lampante la sensibilità e la determinazione di molti Paesi a realizzare politiche paesaggistiche cogenti, con finalità strettamente economiche e/o turistiche o per fare proprie le suggestioni e gli stimoli che provengono dai cittadini.
D E in Italia? Esistono esempi virtuosi da assumere come precedenti o buone pratiche? Mi viene in mente il progetto di paesaggio dello scorso anno a Expo di Franco Zagari e Benedetto Selleri, anche per le implicazioni future, i rischi e le occasioni per immaginare oggi un sistema di infrastruttura verde nell’area Nord, nel contesto della città metropolitana.
Insomma, qual’è in Italia lo stato dell’arte e il destino attuativo del progetto di paesaggio? Quale l’attenzione delle istituzioni e dei rappresentanti del potere politico?
R Esempi virtuosi ci sono in tutto il territorio nazionale. Ma non fanno sistema.
Non ci sono politiche stringenti e iter procedurali semplici per proporre e realizzare progetti di paesaggio.
Si parla molto, ma in maniera generica. Non si realizzano cose elementari, come la detraibilità fiscale per le opere a verde: un sistema adottato per caldaie, infissi, acquisto dei mobili e che non è riuscito a rientrare nella legge di stabilità di quest’anno, nonostante la mobilitazione coesa di tutta la filiera di settore: vivaisti, progettisti, aziende di opere a verde.
I politici di ogni schieramento parlano di paesaggio, ecologia, sostenibilità, promozione turistica del patrimonio paesaggistico, ma le azioni si limitano a pianificare e raccontare progetti, senza passare alla loro realizzazione.
I progetti di paesaggio implicano investimenti di denaro esigui, a volta addirittura minimali rispetto alla maggior parte delle opere pubbliche. Occorre poco per fare molto: si investe in idee, alberi, arbusti, semi e terra e si ottengono ossigeno, benessere, turismo e presidio del territorio. È una situazione quantomeno paradossale che non si riescano a realizzare opere che hanno queste caratteristiche ma forse è proprio per i tempi lunghi che la natura richiede (che sono più lunghi di un mandato elettorale) e la minimalità economica di queste opere che a nessuno interessa sviluppare e promuovere questo settore che – evidentemente – ha budget troppo esigui per essere interessanti, soprattutto per coloro che hanno interesse a far girare molti denari. È un’affermazione grave la mia, ma AIAPP non ha paura a gridare che, nel nostro Paese, da troppi anni il re è nudo.
D Si parla di un documento conclusivo di sintesi che va in direzione di una complessiva maggiore responsabilizzazione di tutti i soggetti protagonisti? Potrebbe anticiparcene i termini?
R Il manifesto focalizza in pochi punti le questioni salienti: qualità dei paesaggi e qualità progettuale, necessità di politiche di governo del paesaggio cogenti, formazione adeguata a tutti i livelli: dall’università, all’aggiornamento professionale a tutte le scale, dai tecnici delle amministrazioni pubbliche ai liberi professionisti, dall’operatore al dirigente.