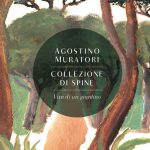Da sempre presenti come un inciampo, una dimenticanza nell’inesorabile (per lo più) proliferare urbano, i prati di città o quelli subito “fuori porta”, spazi comuni spesso vacanti, tornano, se intesi nella loro genesi, per essere occasione di sperimentazione di esperienze e usi condivisi, rinnovati attrattori di immaginari latenti. Spesso situate in zone liminari, o residuali all’interno della città, queste spianate erbose appaiono rivelate nella loro indeterminatezza da una toponomastica che solo a tratti e sovente in sovrapposizione tradisce usi e funzioni volta a volta diverse, di scambio o mercato, militari, ludiche (e quindi politiche), religiose, rituali. Esito sulla lunga durata di circonvoluti processi storici, nel susseguirsi di economie e nuove geografie sociali dove persistono le trame di una significativa dimensione collettiva locale, sono luoghi soggetti a ben determinate temporalità festive o regole (ma pure, per converso, proprio da queste ultime esentati). Luoghi che si costituiscono per tanti versi al negativo, come pause, radure nella selva del costruito – prive però com’è per piazze e parchi, di simbologie e funzioni proprie, chiaramente assegnate e riconoscibili. E ancora slittano e mutano di senso nel più recente, contemporaneo procedere del farsi e disfarsi della risacca di urbanizzazioni fordiste e abbandoni, per cicli e andirivieni di delocalizzazioni e riconfigurazioni variamente urbane e periurbane. E nell’incessante dinamica del loro sfrangiarsi e ricomporsi, risultano perciò vaghi vuoti disponibili, in aspettativa di idee, scenari di opportunità, suscettibili di inediti riadattamenti. Il Museumplein di Amsterdam, la Pelouse de Reuilly a Parigi, i London Fields, il Prado di Madrid, il Prato della Valle a Padova, quello di Bagnoreggio di San Francesco, il Gas Work Park a Seattle, …
Sul tema dei “nuovi prati” si sono appena incentrate, con la consueta, eccentrica tempestività di lettura del farsi soglia di nodi problematici e progettuali, le Giornate internazionali di studio sul paesaggio organizzate dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche, con il coordinamento di Luigi Latini e Simonetta Zanon.
Quest’anno, nella loro tredicesima edizione intitolata appunto a Prati, commons, con sottotitolo, Luoghi di vita pubblica nel paesaggio della città, si sono confrontati a Treviso alcuni tra i maggiori specialisti internazionali di discipline e saperi diversi che orbitano attorno al nodo della cultura del paesaggio inteso nel suo valore di paradigma cognitivo e produttivo.
Con il passo doppio che indaga le relazioni tra città, paesaggio e luoghi collettivi a partire da quei prata, che anche in città quasi sponte proveniunt a natura, si sono incrociati approfondimenti di taglio storico paesaggistico, ricognizioni delle rappresentazioni e dei ruoli attribuiti a questa ulteriore accezione di spazio pubblico da parte della cultura urbanistica e architettonica; analisi di presupposti compositivi e meccanismi di attivazione di pratiche progettuali; confronti tra sperimentazioni in atto ed esperienze temporanee e in divenire.
E se la dotta ricognizione sulla storia dei “prati” di Franco Panzini ha mostrato come la diffusione di queste aree aperte di uso collettivo abbia puntualmente coinvolto il Mediterraneo, per poi trasferirsi precocemente anche nelle città coloniali delle Americhe, Jean Marc Besse si è interrogato su luoghi, pratiche, concetti del paesaggio come «bene comune» e specialmente sulla costruzione del «comune» a partire dal paesaggio. Mentre tra immaginari e pratiche progettuali Jeppe Aagaard Andersen ha analizzato il mosaico di elementi che continuamente ricombinano confini, usi, aspirazioni di luoghi d’incontro fatti per le persone e Marco Bertozzi ha illustrato i suoi Giardini al nitrato, terrain vague digitali. Paesaggi urbani nel cinema.
Paventando le strettoie di una professione progettuale ridotta da un lato al ruolo di “avvocato del verde” e che dall’altro finisce per sacrificare le qualità più essenziali dell’ambiente a funzionalità tutte economiche, Udo Weilacher ripropone di stabilizzare le strutture del paesaggio pubblico nel contesto urbano e Norbert Kühn prospetta per le città l’interazione “intenzionale” dell’uomo con la vegetazione “spontanea”, mentre in dialogo su questo tema con José Tito Rojo, Elisa Tomat, antesignana di una filologica ricomposizione del miscuglio dei prati di erba e fiori selvatici, suggerisce, in una dialettica di intervento dell’uomo e risposta della natura, nuovi modelli compositivi paesaggistici ispirandosi all’ecosistema naturale di piante perlopiù perenni, associate in ricche comunità.
A concludere la sessione dedicata a Lavori in corso: azioni, occupazioni temporanee, nuova vita nei prati, ricordando il valore di opportunità di interventi dove convergono usi anche temporanei di spazi residuali delle città, nuove forme di socialità, pratiche paesaggistiche aperte, Anna Lambertini ha illustrato il caso del Prato della Fiera di Treviso, oggetto lo scorso anno di un workshop inteso a favorire una maieutica di “prove di spazio pubblico”. In questo vuoto urbano in attesa di tornare a esser nuovo prato della città.
Prati, commons. Luoghi di vita pubblica nel paesaggio delle città, Giornate internazionali di studio sul paesaggio promosse dalla Fondazione Benetton Studi e ricerche, 16-17 febbraio 2017, Treviso, coordinamento scientifico di Luigi Latini e Simonetta Zanon, su Alias della Domenica VII, 7, Supplemento de Il Manifesto del 19 febbraio 2017